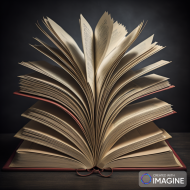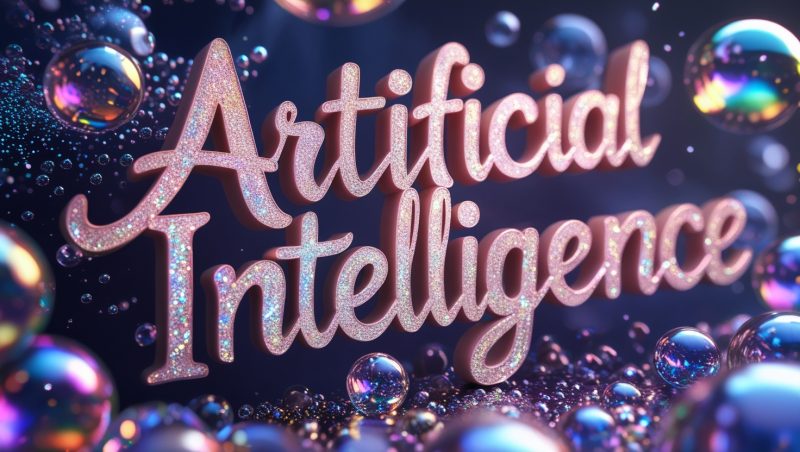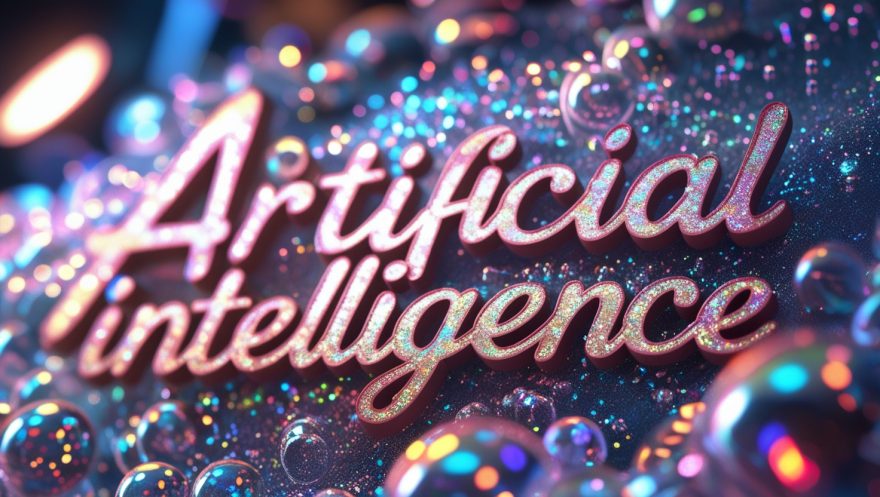Introduzione
Hai comprato un abito nuovo, magari per un’occasione speciale, ma quando lo provi a casa ti accorgi che è difettoso: una cucitura storta, una zip rotta, o un tessuto danneggiato. Cerchi di riportarlo indietro, ma il negoziante si rifiuta di cambiarlo. Cosa puoi fare? E se invece lo hai comprato online, magari su un sito di seconda mano, valgono le stesse regole? In questo articolo facciamo chiarezza su quali sono i tuoi diritti come consumatore, secondo la legge italiana ed europea.
- Quando un abito è “difettoso” secondo la legge
Un abito è considerato difettoso quando non è conforme a quanto promesso dal venditore: ad esempio ha un difetto di fabbrica, è diverso dalla descrizione (colore, taglia, tessuto), oppure non può essere usato per lo scopo normale o promesso.
Questo vale sia per i negozi fisici che per gli acquisti online.
Quando un abito è difettoso secondo il diritto dell’Unione Europea?
Nel diritto dell’Unione Europea, un prodotto è considerato difettoso quando non offre il livello di sicurezza che ci si può ragionevolmente aspettare. Questa definizione vale anche per i capi di abbigliamento, che rientrano a pieno titolo nella nozione di “prodotti” secondo la normativa UE.
La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nella Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, oggi integrata e rafforzata dal nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.
Cosa si intende per “difettoso”?
Un abito è considerato difettoso quando, ad esempio:
Può provocare danni alla salute del consumatore, come nel caso della presenza di sostanze chimiche vietate (es. coloranti tossici, metalli pesanti o formaldeide);
Comporta rischi non segnalati, come una facile infiammabilità, cuciture che si staccano causando inciampi o esposizione corporea;
È etichettato in modo fuorviante oppure mancano informazioni essenziali, come i materiali utilizzati, le istruzioni per il lavaggio o le avvertenze per soggetti allergici;
Non rispetta gli standard minimi di sicurezza previsti per categorie specifiche, come i vestiti per bambini o per attività sportive.
Cosa viene valutato?
Per stabilire se un prodotto è difettoso, si considerano:
La presentazione del prodotto, comprese le etichette, le istruzioni e le informazioni sul marchio;
L’uso previsto o ragionevolmente prevedibile del prodotto da parte del consumatore medio;
Il momento in cui il prodotto è stato messo in commercio, per tener conto dello stato della tecnica disponibile all’epoca.
Quali sono le fonti normative?
Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità da prodotti difettosi;
Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti;
Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), che disciplina le sostanze chimiche vietate nei tessuti;
Eventuali norme nazionali di attuazione e controlli affidati alle autorità di sorveglianza del mercato, come le dogane o le agenzie nazionali per la sicurezza dei consumatori.
- Cosa puoi fare se il negozio non vuole sostituire l’abito difettoso
La legge italiana (Codice del Consumo, art. 128 e seguenti) ti tutela in modo chiaro:
Hai diritto a una sostituzione gratuita o alla riparazione dell’abito, entro 2 anni dall’acquisto, ma solo se trattasi di un difetto congenito del prodotto, e su cui non ci sono dubbi concernenti l’attribuzione. Se il difetto dipende da una condotta errata del proprietario c’è poco da dimostrare.
Se il venditore non vuole collaborare, puoi chiedere una riduzione del prezzo o il rimborso completo.
Il problema va segnalato entro due mesi da quando lo scopri.
✅ Importante: non serve che il difetto si veda subito. Se dopo qualche settimana noti che la cucitura si apre, sei comunque tutelato.
- Gli step pratici da seguire
Conserva lo scontrino o una prova d’acquisto.
Scrivi o torna in negozio spiegando il problema (meglio se con una foto).
Se il negoziante rifiuta, puoi:
Rivolgerti a un’associazione di consumatori
Attivare una procedura di conciliazione
Oppure, come ultima soluzione, andare dal giudice di pace
- E se hai comprato l’abito online?
In caso di acquisto online, le tutele sono ancora più forti, grazie alle norme europee sul commercio a distanza.
Hai 14 giorni per cambiare idea e restituire l’abito anche se non è difettoso (diritto di recesso), senza dover dare spiegazioni.
Se invece è difettoso, valgono le stesse regole dei negozi fisici: diritto a sostituzione, riparazione, rimborso o riduzione del prezzo.
Se il venditore non rispondeva, fino a pochi mesi fa si poteva usare la piattaforma ODR dell’Unione Europea per risolvere la controversia online: https://ec.europa.eu/odr
Solo che al momento la piattaforma è stata archiviata. La piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR) sarà interrotta a partire dal 20 luglio 2025, in seguito all’adozione del regolamento – UE – 2024/3228 – IT – EUR-Lex. Si può utilizzare la piattaforma fino al 19 luglio 2025, ma non si possono più presentare nuovi reclami.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 2024/3228/UE, tutte le informazioni degli utenti, compresi i dati personali, saranno cancellate al più tardi il 20 luglio 2025.
Scadenze importanti
20 marzo 2025: ultima data utile per presentare nuovi reclami sulla piattaforma ODR.
19 luglio 2025: termine ultimo per accedere alla piattaforma e scaricare i propri dati.
20 luglio 2025: tutti i dati presenti sulla piattaforma, compresi quelli personali, saranno definitivamente cancellati.
🔄 Cosa accadrà dopo la chiusura della piattaforma ODR?
Dopo la dismissione della piattaforma ODR, i consumatori potranno continuare a risolvere le controversie con i venditori attraverso organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) certificati. La Commissione europea sta lavorando per migliorare l’accessibilità e l’efficacia di questi meccanismi, anche mediante l’adozione di nuove direttive che estendono l’ambito di applicazione delle procedure ADR e introducono strumenti digitali interattivi per facilitare la risoluzione delle controversie.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla risoluzione delle controversie dei consumatori, puoi consultare il sito ufficiale della Commissione europea dedicato alla risoluzione online delle controversie:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT
- Abiti usati acquistati online: cosa cambia?
Se compri un abito usato su una piattaforma online, la tutela dipende da chi vende:
Se compri da un’azienda (es. negozio vintage online o marketplace professionale): hai gli stessi diritti di chi compra un capo nuovo.
Se compri da un privato (es. su Vinted, Depop, Facebook Marketplace): non vale il Codice del Consumo. In quel caso si applicano le regole del Codice Civile, e la responsabilità del venditore è molto più limitata.
ℹ️ Consiglio: leggi sempre le condizioni di vendita e cerca venditori che offrano garanzie o recensioni positive, stando attento a recensioni false e pompate.
- Riferimenti normativi
Direttiva UE 2019/771 – obblighi di conformità dei beni (valida per tutti i Paesi UE)
Regolamento UE 524/2013 – per risolvere le controversie online
Codice del Consumo italiano (D.lgs. 206/2005), articoli 128-135
D.lgs. 170/2021 – ha aggiornato le regole sulla garanzia dei beni
Conclusione
Che tu abbia comprato in boutique o online, la legge è dalla tua parte: se l’abito è difettoso, il venditore deve trovare una soluzione. E se non lo fa, puoi far valere i tuoi diritti in modo semplice e spesso gratuito. Conoscere le regole è il primo passo per far valere i propri diritti, anche quando si tratta solo di una zip che non si chiude.